Il trionfo della leggenda
A cura di Domenico Rizzi
Link dello speciale sul genere western: 1) Il tesoro del west, 2) Il trionfo della leggenda, 3) L’ascesa del western, 4) Il periodo d’oro, 5) Ombre rosa nella prateria, 6) Orizzonti sconfinati, 7) I sentieri del cinema, 8) Orizzonti sconfinati, 9) La quarta frontiera
Segue da Il tesoro del west
 Commerce Of The Praires
Commerce Of The Praires
Nella prima metà dell’Ottocento si diffusero molto i resoconti delle esplorazioni compiute nel West e delle imprese di uomini come Meriwether Lewis, William Clark, Stephen H. Long, Louis de Bonneville, John Charles Frèmont e diversi altri, mentre fiorivano le biografie dei più noti personaggi della Frontiera.
Il materiale storico che raccontava le tappe della conquista del West si accrebbe sempre più di diari di viaggio di carovane e cow-boys, esperienze di vita nell’Ovest, narrazioni di spedizioni contro gli Indiani, duelli e sfide nelle città calde del Kansas, dell’Arizona e del Texas. Mentre la gente dell’Est leggeva ammirata i “Journals of the Lewis and Clark Expedition”, Josiah Gregg descriveva le notevoli possibilità di scambio offerte dalla Pista di Santa Fè in “The Commerce of the Prairies”.
Nello stesso tempo Padre Jean De Smet pubblicava nel 1847 “Oregon Missions and Travels Over the Rocky Mountains” e cominciavano a circolare i rapporti dei militari che avevano trascorso gran parte della loro vita negli avamposti occidentali, come quello del colonnello Randolph Barnes Marcy, “Thirty Years of Army Life on the Border”, pubblicato a New York nel 1866 e gli articoli del generale Custer sulla rivista “Galaxy”, che sarebbero stati raccolti nel volume “My Life on the Plains” nel 1876.
Anche le donne avrebbero dato un notevole contributo alla storiografia del West. Catherine Beecher – sorella della più celebre Harriet Beecher Stowe, autrice de “La capanna dello zio Tom” – diede alle stampe “The Duty of American Women to Their Country”, invitando le giovani dell’Est a trasferirsi ad occidente, assai prima che la medesima sollecitazione venisse espressa verso i maschi più intraprendenti da Horace Greeley.
Il libro di Fanny Kelly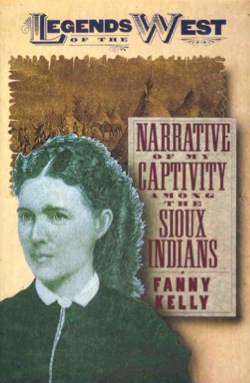
Diversi anni più tardi sarebbero apparsi altri libri assai meno incoraggianti, scritti da vittime della violenza del West, quali “Narrative of My Captivity Among the Sioux” di Fanny Kelly, ma anche gli appassionati racconti “Boots and Saddles”, “Following the Guidon” e “Tenting on the Plains” di Elizabeth Bacon, vedova di Custer, pubblicati fra il 1885 ed il 1893: un accorato tributo al marito ed alle sue imprese nella prateria, ma anche un nostalgico ricordo dei migliori anni vissuti insieme a lui nel selvaggio West.
La figura del “frontiersman” indomito e spietato – sceriffo, cacciatore di bisonti, esploratore, guida – sembrava tuttavia esercitare un fascino maggiore sulla gente assetata di racconti d’avventura, nonostante la promessa di John Colter, scampato miracolosamente alla furia dei Piedi Neri, che non avrebbe mai più rimesso piede in quel “maledetto West”.
Dopo gli innumerevoli racconti di Ned Buntline intorno alle figure di Buffalo Bill e Texas Jack e quelli dedicati a Kit Carson e Jim Bridger, J. W. Buell scrisse “Life and Marvelous Adventures of Wild Bill Hickok”, edito a Chicago nel 1880. Qualche altro cronista in cerca di gloria cercava di approcciare addirittura personaggi come Billy the Kid, Raymond S. Spears aveva la fortuna di conoscere Butch Cassidy e il giovane regista cinematografico John Ford sarebbe diventato amico dell’anziano Wyatt Earp, il “marshall” che aveva sgominato i Clanton all’O.K. Corral.
Premesso ciò, l’attenzione del grosso pubblico e degli adolescenti era polarizzata dalla componente “eroica” del West, quella delle donne dal romanticismo che dominava gli scenari avventurosi. In questo senso, James Fenimore Cooper, con il suo “L’ultimo dei Mohicani”, aveva stabilito un percorso quasi obbligato, tracciando degli archetipi sui quali si sarebbero orientati molti autori. Anche Washington Irving, divenuto celebre con il romanzo “La leggenda di Sleepy Hollow”, trasse ispirazione da un viaggio compiuto nel West insieme al commissario per gli Affari Indiani Henry Ellsworth, per scrivere “A Tour on the Prairies”, che ottenne grande successo.
 Un libro di Ned Buntline
Un libro di Ned Buntline
Nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del secolo successivo, il tema dell’eroe “senza macchia e senza paura”, nutrito di ideali intramontabili e proteso verso la difesa degli umili e dei diseredati assetati di giustizia, avrebbe costituito il polo di riferimento della narrativa western. Non a caso, scrittori come Ned Buntline avevano insistito, indovinando i gusti dei lettori, sull’aspetto più nobile delle gesta di Bill Cody e degli altri uomini della Frontiera, pur consapevoli di calpestare spesso il solco severo della storia. Ormai spalancata la via del western mitico ed immaginario, non tardarono ad emergere e a farsi strada scrittori fantasiosi e determinati a tuffarsi nel nuovo genere.
I primissimi anni del nuovo secolo registrarono una vera e propria escalation del western, sia dal punto di vista letterario che cinematografico.
Nel 1903 il genere emergente si impose agli spettatori con due film che si contesero lungamente il primato dell’esordio. Il primo, “Kit Carson” del regista Wallace Mc Cutcheon, prodotto nel 1903 dalla American Mutoscope & Biograph, raccontava in 11 episodi le gesta del celebre eroe morto nel 1868; il secondo e più noto lavoro – “L’assalto al treno”, diretto da Edwin S. Porter per conto della Edison – lo seguì di pochi mesi, ma sarà sempre ricordato come l’antesignano del cinema western.
Ma poco tempo prima, era accaduto anche un altro evento di rilievo. Nell’aprile 1902 Owen Wister aveva pubblicato “Il Virginiano”, considerato il romanzo-principe e l’iniziatore del nuovo filone western, che assume come protagonista il “cow-boy”, il conduttore delle mandrie fino a quel momento relegato in un ruolo minore rispetto ai tradizionali stereotipi del West. Il cinema ne elaborerà proprie versioni nel 1914, sotto la direzione di Cecil B. De Mille e nel 1929, con la regia di Victor Fleming e l’interpretazione di un giovane e promettente Gary Cooper, proprio un ex mandriano del Montana. In otto mesi, il romanzo di Wister ebbe quattordici ristampe, segno che la “new wave” incontrava i favori del pubblico e in breve tempo l’autore divenne il padre della “western fiction”, titolo di merito che dovrà condividere con Zane Grey.
 Benchè il soggetto non fosse eccessivamente elaborato, conteneva dei canoni basilari che avrebbero formato il sostrato delle storie di frontiera. Esso percorreva la lunga storia di un “frontiersman” fino alla sua trasformazione in uomo d’affari, quindi l’intera parabola evolutiva del West, anticipando a grandi linee diverse altre opere, fra cui “Il gigante”, di Edna Ferber, pubblicato nel 1952 ed assurto a grande notorietà per merito dell’omonimo film di George Stevens del 1956. “Il Virginiano” è la performance del mandriano che rimane attaccato alle sue radici, ai suoi modi di vivere e di pensare, senza essere contaminato da un progresso invasivo, quanto povero di modelli imitativi. Il West, lungi dall’essere soltanto una realtà geografica, è il principio rigeneratore, la fucina dell’uomo puro, sorretto dalla sua forza e caparbietà, contrapposta alla “mollezza” dell’uomo ormai civilizzato delle grandi città dell’Est.
Benchè il soggetto non fosse eccessivamente elaborato, conteneva dei canoni basilari che avrebbero formato il sostrato delle storie di frontiera. Esso percorreva la lunga storia di un “frontiersman” fino alla sua trasformazione in uomo d’affari, quindi l’intera parabola evolutiva del West, anticipando a grandi linee diverse altre opere, fra cui “Il gigante”, di Edna Ferber, pubblicato nel 1952 ed assurto a grande notorietà per merito dell’omonimo film di George Stevens del 1956. “Il Virginiano” è la performance del mandriano che rimane attaccato alle sue radici, ai suoi modi di vivere e di pensare, senza essere contaminato da un progresso invasivo, quanto povero di modelli imitativi. Il West, lungi dall’essere soltanto una realtà geografica, è il principio rigeneratore, la fucina dell’uomo puro, sorretto dalla sua forza e caparbietà, contrapposta alla “mollezza” dell’uomo ormai civilizzato delle grandi città dell’Est.
Negli anni immediatamente successivi, si fanno largo nuovi autori che spesso ripetono il medesimo clichè wisteriano. Andy Adams scrive “The Log of a Cow-boy” nel 1905, Frank H. Spearman “Whispering Smith” (1907) e Stewart E. White “Arizona Nights” nel 1910, lo stesso anno in cui qualcun altro corona finalmente il sogno di vedere il suo primo romanzo andare a ruba. Si chiama Pearl Zane Gray, ma non tarderà a semplificare il proprio nome, modificandolo in Zane Grey.
Nato a Zanesville, Ohio, nel 1872, laureatosi in medicina con la specializzazione di odontoiatra nel 1896, Grey esercitò per alcuni anni la professione, la stessa di suo padre, a New York, trovandovi sempre meno interesse. Fortemente portato all’evasione e appassionato d’avventura, maturò dentro di sé la convinzione che la sua vera strada fosse quella dello scrittore, ma si trovò a percorrere un sentiero costantemente in salita.
Dopo il matrimonio con Lina “Dolly” Roth, abbandonò il lavoro di dentista per dedicarsi completamente alla stesura di romanzi, attratto dal fascino della Frontiera dopo avere letto le memorie di suo bisnonno, il colonnello Ebenezer Zane, pioniere e combattente nella guerra di indipendenza americana. Nel 1903 aveva già ultimato il suo manoscritto “Betty Zane”, che consegnò alla Harper’s & Brothers l’anno seguente, ma la risposta dell’editore fu negativa. Deciso a non arrendersi, Gray pubblicò allora il volume a proprie spese, ma la risposta del pubblico fu altrettanto deludente. Nel 1906 scrisse un altro libro, “The Spirit of the Border” con analogo risultato, facendo crescere la propria amarezza: “Ciò che io voglio scrivere” annotò “non pare interessare gli editori…”
Tuttavia, il successo si trovava appena dietro l’angolo.
Un fortunato viaggio da lui organizzato l’anno dopo nella zona del Grand Canyon, per dare la caccia al puma, gli fornì l’occasione per conoscere da vicino le selvagge terre dell’Ovest. Grey prese una quantità enorme di appunti e quando tornò all’Est aveva aumentato considerevolmente il proprio bagaglio di nozioni. All’insuccesso di “L’ultimo dei Plainsmen”, che narrava le avventure di Buffalo Jones, seguì finalmente la pubblicazione di “L’eredità del deserto” nel 1910. Scritto in soli 4 mesi, il libro diventò subito un best-seller, come la maggior parte di quelli che scriverà in seguito. In breve tempo, Grey ottenne la nomina di miglior scrittore popolare e padre della letteratura western e il cinema cominciò ad attingere a piene mani ai suoi lavori, mentre qualche editore si rammaricava di averli visionati superficialmente e scartati troppo in fretta.
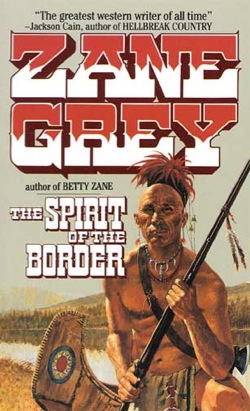 Durante la sua carriera, l’autore creò, secondo alcuni critici, 78 romanzi a firma sua, ma includendo le opere di saggistica ne realizzò addirittura 93, alcune pubblicate dopo la sua morte, avvenuta nel 1939. Senza la pretesa di essere esaustivi, si può citare, fra la sua produzione più signficativa, “The Last Trail”, “Riders of the Purple Sage”, “The Lone Star Ranger”, “The Desert of Wheat”, “The Vanishing American Indian”, “Nevada”, “West of the Pecos”, “Knights of the Range”, “The Maverick Queen” e “Captives of the Desert”.
Durante la sua carriera, l’autore creò, secondo alcuni critici, 78 romanzi a firma sua, ma includendo le opere di saggistica ne realizzò addirittura 93, alcune pubblicate dopo la sua morte, avvenuta nel 1939. Senza la pretesa di essere esaustivi, si può citare, fra la sua produzione più signficativa, “The Last Trail”, “Riders of the Purple Sage”, “The Lone Star Ranger”, “The Desert of Wheat”, “The Vanishing American Indian”, “Nevada”, “West of the Pecos”, “Knights of the Range”, “The Maverick Queen” e “Captives of the Desert”.
E’ superfluo specificare che la Frontiera americana fu il suo campo di battaglia preferito. “Il Far West” per citare Graziano Frediani “era per Zane Grey una terra eccitante e favolosa, una insuperabile fucina di eroi, che il progresso proveniente dall’Est aveva irrimediabilmente minato e distrutto”.
In possesso di uno stile sobrio ed efficace, estremamente incisivo nella rappresentazione di personaggi, animali e luoghi e sospinto da un entusiasmo che non conosceva cedimenti né flessioni, Grey tenne alta la bandiera dell’avventura vissuta all’insegna di un progetto da realizzare, di una vita da riscattare, di un nuovo mondo da costruire.
La descrizione dei suoi scenari è ad un tempo lineare e coinvolgente. “Ella aveva imparato a giudicare il colore dato dalla distanza “ scrive nel suo libro “Wild Home Mesa” (Il cavallo selvaggio) “le ingannevoli ombre purpuree, le lunghe linee del deserto. Ma là vedeva una valle dall’estensione…di dieci miglia per trenta, Vista così, nel vastissimo panorama, sembrava quasi ristretta, chiusa ad un lato da una linea nera e frastagliata di montagne e dall’altra da un altipiano immenso, di un verde ondeggiante, che pareva pendere da un lato all’altro dell’orizzonte”.
Il suo amore per gli animali che popolano le solitudini selvagge non è inferiore al sentimento che prova per i suoi protagonisti. “Chane giudicava i cavalli così come giudicava gli uomini: guardandoli negli occhi. I cavalli, diceva, hanno un carattere, non diversamente dagli uomini, e come questi hanno anche emozioni ed istinti; e sosteneva, contrariamente al parere di molti allevatori, che la dolcezza può sviluppare le loro migliori e più nascoste qualità. Se un cavallo vale poco o è cattivo, ciò non significa che sia nato così” (“Il cavallo selvaggio”)
Una caratteristica comune a questi scrittori affermatisi nel primo decennio del Novecento è l’acceso patriottismo, un aspetto edificante che li spinge ad esaltare le qualità migliori dell’uomo proteso nella conquista delle grandi pianure.

Una famiglia di “ruvidi” pionieri
Il difetto principale è invece l’impronta marcatamente conservatrice che li porta talvolta alla discriminazione, in qualche caso con marcati accenti xenofobi. Forse perché troppo immedesimati nelle figure dei loro personaggi, considerano superiore la cultura formatasi nell’Ovest rispetto a quella che i “piedi teneri” dell’Est vorrebbero estendere, servendosi degli strumenti offerti dalla tecnologia. La certezza che soltanto l’uomo del West, di razza bianca, provenienza anglosassone e fede protestante – “White, Anglo-Saxon, Protestant” – incarni lo spirito della vera America, li conduce talvolta ad eccessi non condivisibili. Grey assunse addirittura atteggiamenti reazionari di fronte ai fermenti sociali che turbavano l’America del primo Novecento, esecrando la protesta degli operai delle fabbriche e dei braccianti agricoli, ai quali contrapponeva idealmente la “ruvida gente del West e gli uomini taciturni e laboriosi che avevano trasformato la Frontiera in una società civile”.
Tuttavia, le loro opere, spesso seguite da tirature molto elevate, li posero al centro delle attenzioni del pubblico e della critica, rappresentando una inesauribile miniera di spunti per la nascente settima arte. La maggior parte dei romanzi di Zane Grey, se non quasi tutti, andarono ad alimentare la lunga schiera di film western che circolarono nelle sale cinematografiche nel periodo precedente la seconda guerra mondiale.
Di tendenze decisamente opposte, sebbene non lo si possa rigorosamente annoverare fra gli scrittori di western, se non per qualche opera – “Il richiamo della foresta”, 1903 e il celeberrimo “Zanna Bianca”, 1906 – Jack London, che aveva fatto tesoro della sua esperienza fra i minatori durante l’ultima corsa all’oro nel Klondike.
La sua frontiera è quella dei diseredati e degli emarginati, ma l’impatto dell’autore con la “wilderness” non ha il medesimo significato. La sua filosofia contiene, seppure confusamente e con molte contraddizioni, il germe della lotta di classe, i toni sono più esasperati ed il contesto in cui si muovono i suoi personaggi assume i risvolti di una spietata battaglia per la sopravvivenza. Neppure la celebrazione delle qualità del “westerner” cantata da Wister e Grey presenta tratti comuni con l’esaltazione londoniana del superuomo: se il mondo della Frontiera è uno stimolo a sviluppare una cultura propositiva, basata su sane concezioni dell’esistenza, la disperata lotta per la vita nelle desolazioni ghiacciate del grande Nord racchiude un fatalismo che prelude all’autodistruzione di London, scomparso appena quarantenne, si ritiene, per suicidio.

Jack London sul patio della sua casa
Ma gli Americani non erano gli unici a sfruttare la ricchezza del West. Com’era già avvenuto con Mayne Reid, Karl May e Gustave Aimard, anche gli Europei si lasciarono attrarre dal fantastico mondo della Frontiera.
Uno di questi non poteva che essere l’italiano Emilio Salgàri, padre di Sandokan e del Corsaro Nero, ancora oggi uno degli scrittori d’avventura più conosciuti nel mondo.
Nato a Verona nel 1862, Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgàri – pronunciato spesso come Sàlgari – si rivelò come fantasioso narratore fin dai primi anni della giovinezza, pubblicando a puntate su un settimanale di Milano “I selvaggi della Papuasia” nel 1882 e appassionandosi in seguito al mondo esotico dell’Oriente ed a quello dei corsari delle Bermude, senza disdegnare frequenti sconfinamenti in altri campi. Non a torto, l’autore è considerato uno dei precursori della fantascienza, per alcune opere fra le quali primeggia “Le meraviglie del Duemila”, del 1907.
Iscrittosi al Regio Istituto “Paolo Sarpi” di Venezia, non conseguì mai l’agognato brevetto di “Capitano di gran cabotaggio”, anche se lasciò intendere in seguito di esserne in possesso. I suoi viaggi si limitarono ad una crociera nell’Adriatico, forse con un’escursione alle isole dell’Egeo occidentale. La sua fantasia, invece, navigò in tutto il mondo.
Nel 1890 accadde un evento che spinse il nostro autore nell’orbita delle “western stories”. A Salgari erano noti gli episodi salienti della conquista del West, dalle guerre indiane alle biografie di qualche personaggio della mitica Frontiera, ma decisivo per lui si rivelò l’incontro con il colonnello William Frederick Cody, che durante la sua lunga tournèe in Italia fece visita a Verona, la città natale dello scrittore. Scriverà infatti su “L’Arena” il 15 aprile 1890: “Buffalo Bill si è presentato sul suo vecchio cavallo grigio, che per tanti anni lo ha trasportato attraverso le praterie americane. E’ un bell’uomo, quel colonnello, di alta statura, di forme sviluppatissime, con lungo pizzo e lunghi capelli brizzolati” aggiungendo con disappunto che “il pubblico ha fatto un’accoglienza piuttosto fredda alla compagnia di Buffalo Bill… Tale non è la nostra opinione… A Milano e a Bologna ha furoreggiato ed ha interessato assai i romani, i napoletani, i parigini e i londinesi”.
L’occasione fornì a Salgari l’idea di scrivere romanzi ambientati nel West. Uno dopo l’altro, si susseguirono infatti “Sulle frontiere del Far West” (1908) “La scotennatrice” (1909) e “Le selve ardenti” (1910), che hanno come protagonisti il colonnello Giorgio Devandel e la feroce Minnehaha, calandosi, con molta inventiva e poca aderenza storica, anche nella cruenta battaglia del Little Big Horn, nella quale “i disgraziati soldati del governo dell’Unione non si difendevano più.

Buffalo Bill e i suoi indiani a Venezia
Si lasciavano sterminare appoggiati ai loro rifles che non potevano più sparare per mancanza di munizioni. E caddero tutti, fino all’ultimo, compreso il generale…Quando non vi fu in piedi più nessuno, Sitting Bull, armato d’un tomahawk, scese solo nel canyon, s’avanzò attraverso quella distesa di cadaveri, raggiunse il generale che era caduto in mezzo ai suoi ultimi ufficiali, gli spaccò il petto e levatone il cuore che era ancora caldo, lo divorò con l’avidità di un antropofago, fra le urla entusiastiche dei suoi quattromila guerrieri”
Ovviamente, le cose non andarono proprio così, dal momento che il cadavere di Custer venne rinvenuto quasi intatto dai soccorritori, ma Salgari, premuratosi di sottolineare la storicità del fatto descritto, era abituato ad affidarsi alla propria inventiva, compensando talvolta le lacune derivanti dalla scarsità di informazioni su un determinato episodio.
La grandezza del romanziere risiede nel suo vigore narrativo, nella capacità di ricreare per il lettore il proscenio che fa da sfondo ai personaggi del filone avventuroso. Come negli innumerevoli altri suoi lavori ambientati in India, in Malesia o nei Caraibi, anche in queste opere western Salgari dà un saggio della sua abilità descrittiva: “L’alba spuntava, e le nevi che coprivano tutta l’alta prateria si tingevano vagamente di rosa. Il sole si sforzava di mostrarsi attraverso un denso strato di nebbie che imprigionavano i suoi raggi. Tutto il campo si era svegliato. Quegli uomini che durante la notte avevano vegliato accanto ai fuochi ormai morenti, si affrettavano a ritirarsi sotto i wigwams per prendere un po’ di riposo, mentre gli altri, che avevano dormito, uscivano a governare i cavalli, aiutati da un centinaio di donne e da una folla di fanciulli sgambettanti, seminudi, fra la neve” (“Le selve ardenti”).
L’universo salgariano è popolato di figure che simboleggiano l’eterna lotta del bene contro il male, dell’uomo leale e animato da giusti principi contro l’ingiustizia del mondo e le oscure trame di affaristi e speculatori. Questo manicheismo si attenua a tratti in alcune opere, nella quali l’autore, pur sostenendo l’azione dei suoi eroi, condivide le ragioni della controparte, come accade in “Le selve ardenti”, dove Salgari spezza una lancia in favore degli Indiani: “Le angherie degli agenti governativi e le continue usurpazioni da parte dei coloni che salivano, come marea infinita, dall’Occidente, li avevano esasperati”. Così, anche la figura del suo Devandel non appare del tutto limpida, celando un discutibile passato in cui aveva abbandonato la moglie pellerossa di nome Yalla, torto che la figlia Minnehaha si propone di vendicare.
In tutti e tre i romanzi Salgari non risparmia scene cruente, come l’uccisione di Custer e lo scotennamento di Yalla, macabri rituali che egli ripete più volte nel corso della lunga narrazione. L’opera è un intreccio tra personaggi realmente esistiti – Nube Rossa, Toro Seduto, il generale Crook, lo stesso Custer – ed immaginari – Devandel, Yalla, Minnehaha, Sandy Hook – che prendono il posto dei vari Sandokan, Sambigliong, Yanez de Gomera delle precedenti opere. Manca invece, in questi racconti, una contrapposizione netta, come nel ciclo malese (Sandokan e Sir Brooke) o dei corsari (il Corsaro Nero e Van Gould) fra buoni e cattivi. Ma anche qui, i suoi personaggi – che siano di pelle bianca o ramata – sono sempre e comunque dei capi, spesso dalle origini nobiliari. La trilogia della frontiera rispetta dunque l’impostazione di base del mondo salgariano, nel quale lo scontro avviene sempre tra persone di un certo rango.
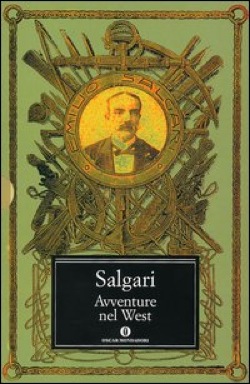 Neppure le sue eroine si sottraggono ad un simile retaggio: come Lady Marianna, la “Perla di Labuan”, innamorata di Sandokan e Honorata Van Gould, la donna ambita dal Corsaro Nero, anche Minnehaha è una principessa. Tuttavia, assecondando il suo socialismo un po’ elitario, Salgari ne fa dei personaggi condivisi, amati e seguiti dalle masse.
Neppure le sue eroine si sottraggono ad un simile retaggio: come Lady Marianna, la “Perla di Labuan”, innamorata di Sandokan e Honorata Van Gould, la donna ambita dal Corsaro Nero, anche Minnehaha è una principessa. Tuttavia, assecondando il suo socialismo un po’ elitario, Salgari ne fa dei personaggi condivisi, amati e seguiti dalle masse.
Le molte esagerazioni ed alterazioni storiche dell’autore veronese – Toro Seduto che ha “15.000 guerrieri ai suoi ordini” (“Le selve ardenti”) oppure che leva in alto il cuore fumante strappato a Custer davanti a “4.000 guerrieri” (“La scotennatrice”) sono giustificate dal fatto che la stampa dell’epoca fornì spesso resoconti poco fedeli degli avvenimenti, alterandone lo svolgimento per dare maggior risalto al valore di alcuni personaggi, come Toro Seduto e Cavallo Pazzo. A ciò si deve aggiungere che Salgari, dopo essere entrato in contatto con Buffalo Bill, si lasciò contagiare dall’atmosfera del West mitico e leggendario, che non mostrava troppo riguardo per la verità storica.
Sebbene fossero stati pubblicati molti altri resoconti sulla realtà dell’Ovest – come “My Army Life and the Fort Phil Kearny Massacre” di Frances C. Carrington (1910) e “Vanished Arizona”, di Martha Summerhays (1911) che raccolgono le drammatiche esperienze di due mogli di militari negli sperduti avamposti occidentali – la gente amava molto di più il West della leggenda e andava a caccia di libri che esaltassero le imprese di uomini eroici, narrando di travolgenti amori vissuti su un “Conestoga” in marcia verso l’Oregon, in un piccolo “ranch” del Texas o sotto l’oceano di stelle che illuminava le notti della prateria, fra profumi di salvia selvatica e superbi cactus in fiore. L’Arizona, reciterà un popolare motivo musicale italiano del 1928, era soprattutto “terra di sogni e di chimere”, immagine che anche la cinematografia western aveva contribuito a creare lanciando sullo schermo le figure degli eroi a cavallo – Tom Mix, Roy Rogers – timidamente innamorati di pallide fanciulle minacciate da malvagi pretendenti.
Come dirà John Ford qualche anno dopo, “quando la storia si scontra con la leggenda, è sempre la leggenda a prevalere”.
Prossima puntata: Ombre Rosse
