Ombre rosa nella prateria
Il suo primo manoscritto, “Old Jules”, completato nel 1929, venne bocciato da diversi editori e spinse addirittura l’autrice a bruciare altri lavori in preparazione, nella convinzione che non sarebbe mai riuscita a pubblicarli. Dovettero trascorrere ben sei anni prima che la Sandoz, che non aveva perso tutte le speranze, riuscisse finalmente a farsi un nome come scrittrice.
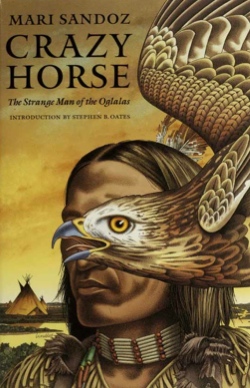 Crazy Horse, di Mari Sandoz
Crazy Horse, di Mari Sandoz
Dopo essere diventata co-editrice del “Nebraska History Magazines” nel 1934, il libro “Old Jules” andò finalmente in stampa l’anno successivo ed incontrò un buon successo di pubblico. I suoi due romanzi successivi – “Slogum House” (1937) e “Capitol City” (1939) – la resero però impopolare. Secondo i suoi detrattori, nel primo libro la Sandoz esprimeva un giudizio eccessivamente critico nei confronti dei contadini del Nebraska, mentre “Capitol City” denigrava la stessa capitale dello Stato. La pubblicazione di “Crazy Horse”, tre anni più tardi, la fece di nuovo apprezzare come saggista e biografa, attirandole le simpatie di chi condivideva la passione per gli Indiani e perorava la loro causa. La scrittrice – che aveva usato agli esordi il cognome da sposata – portò a termine diversi altri romanzi, fra i quali “Cheyenne Autumn”, “The Buffalo Hunter”, “The Cattlemen”, “The Horse Catcher”, “The Story Catcher” e “The Beaver Man”, pubblicati dal 1953 al 1964.
Il primo, stampato nel 1953, ispirò a James R. Webb e Patrick Ford la sceneggiatura dell’omonimo film diretto da John Ford, distribuito in Italia con il titolo “Il grande sentiero” nel 1964. Lo stesso anno la Western Writers Association conferì a Mari l’”Owen Wister Award”, uno dei premi più prestigiosi riservati agli scrittori western. La vita della Sandoz si interruppe poco tempo dopo, nel 1966, a causa di un cancro osseo, quando aveva raggiunto i 69 anni. Nonostante le sue opere di narrativa, oggi è nota soprattutto per l’opera biografica su Cavallo Pazzo, che viene ripetutamente citata in diversi libri di storia della Frontiera.
Sylvia Richards, che è scomparsa nel 1999, fu soprattutto un’abilissima sceneggiatrice cinematografica. Suo è il soggetto di “Tomahawk” (“La scure di guerra”, 1951) di George Sherman – uno dei pochissimi film imperniati sull’assedio di Fort Phil Kearny nel 1866-67 – ricavato dal libro di Daniel Jarrett, come pure quello del celebre “Rancho Notorius” di Fritz Lang (1952) tratto dal suo racconto “Gunsight Whitman” e sceneggiato da Daniel Taradash.
Laura Ingalls ebbe la fortuna di legare la propria firma ad un serial televisivo di grande popolarità, conosciuto in Italia come “La casa nella prateria”.
Il poster di Tomahawk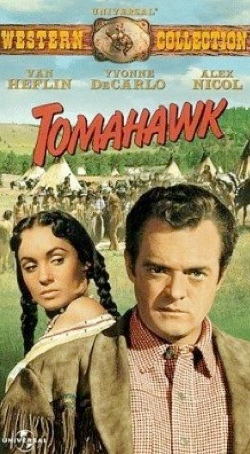
Il primo di questi episodi deriva da un romanzo del 1932 intitolato “Little House in the Big Woods” (“La piccola casa nei grandi boschi”) che la scrittrice sviluppò quando aveva già 65 anni. Essendo una donna cresciuta ai tempi del West – era nata nel 1867 nel Wisconsin, ma in seguito la sua famiglia si era trasferita nel Minnesota, nel Kansas e poi nel Territorio del Dakota – la Ingalls fece tesoro di queste sue esperienze personali, trasferendole in 9 romanzi. Nel Dakota Laura fece anche l’insegnante per qualche tempo, ma dovette interrompere l’attività nel 1885 in seguito al matrimonio con Almanzo Wilder, non essendo consentito dalle leggi locali insegnare alle donne coniugate.
Nei suoi libri – ricordiamo, oltre a quelli citati, “On the Banks of Plum Creek”, “Little Town on the Prairie” e “Farmer Boy” – la Ingalls cercò di spiegare ai ragazzi delle nuove generazioni le trasformazioni epocali subite dall’America, dai tempi del vecchio West all’era moderna. La televisione trasmise a puntate “La casa nella prateria” molti anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1952. Negli Stati Uniti la felice serie – ambientata a Walnut Grove, nel Minnesota – durò dal 1974 al 1983, mentre in Italia venne proposta una prima volta nel 1977 e rilanciata, su un canale diverso, nel 1984. Recentemente le vicende ad episodi della famiglia Ingalls sono state messe in circolazione in DVD anche nel nostro paese.
Mary O’Hara, nata nel 1885 a Cape May nel New Jersey, lontana discendente di William Penn, il fondatore della Pennsylvania, è l’esempio di un’altra donna dell’Est pervasa da una travolgente passione per il West, dove era emigrata nel 1922, subito dopo il suo secondo matrimonio (si era sposata la prima volta nel 1905, appena ventenne, con un cugino, nonostante l’opposizione della propria famiglia). La coppia acquistò infatti una fattoria, il Remont Ranch, nel Wyoming, dove Mary visse il periodo della sua maggiore ispirazione. Aveva già curato la sceneggiatura de “Il prigioniero di Zenda”, tratto dalla novella di Anthony Hope e portato sullo schermo da Rex Ingram nel 1922. Nel 1925 preparò anche quella di “Braveheart” (1925) per la regia di Alan Hale, ma soltanto negli Anni Quaranta si sarebbe dedicata a scrivere romanzi di successo.
Un libro di May O’Hara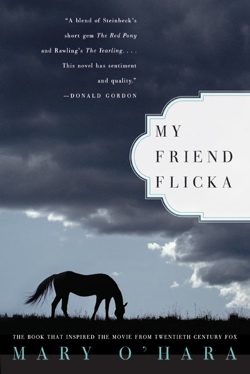
La sua trilogia western, composta da “My Friend Flicka” (1941) “Thunderhead” (1943) e “Green Grass of Wyoming” (1946) diede lo spunto ad altrettanti film prodotti tra il 1943 ed il 1948. Il personaggio di spicco è un ragazzo, Ken Mc Laughlin, alle prese con un selvaggio stallone bianco, che dopo avere creato problemi agli allevatori per molti anni, si trasforma, dopo infinite cure, in un cavallo da corsa. L’ambientazione è la più classica della letteratura western, il “mare d’erba” del Wyoming, dove appunto la O’Hara aveva trascorso i suoi anni migliori. Soltanto dopo il secondo divorzio, nel 1947, la scrittrice se ne tornò all’Est, stabilendosi a Monroe, nel Connecticut, dove continuò a scrivere, coltivando parallelamente la sua seconda passione, quella della musica. Infatti Mary era anche una brava pianista e compositrice ed uno dei suoi pezzi migliori prese il nome dal terzo romanzo della trilogia: “L’erba verde del Wyoming”. Inquieta e sempre in cerca di nuove dimore che stimolassero il suo estro creativo, come gli autentici Americani della Frontiera, nel 1968 si trasferì a Cherry Chase, nel Maryland, dove rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1980.
Un posto particolare merita Edna Ferber, di origini ungheresi, nata nel 1885 in una cittadina del Michigan ed emigrata all’età di 12 anni nel Wisconsin, dove ottenne il diploma di scuola superiore e si laureò alla Lawrence University. Dopo avere scritto il suo primo romanzo nel 1911, proseguì nella carriera di scrittrice, vincendo nel 1924 il Premio Pulitzer con l’opera “So Big”. La Ferber, che si dedicò molto anche al teatro, è importante nella letteratura western per due opere che il cinema seppe trasformare in altrettanti colossal, seppure senza la pretesa di rappresentarne appieno la profondità.
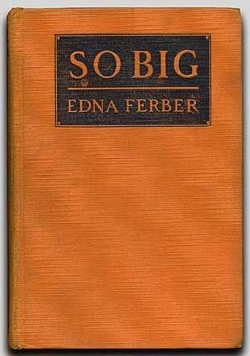 So Big, di Edna Ferber
So Big, di Edna Ferber
La prima, del 1929, è “Cimarron”, da cui il regista Wesley Ruggles, con l’aiuto dello sceneggiatore Howard Eastabrook, trasse nel 1931 un celebre film, riproposto nel 1966 da Anthony Mann con il medesimo titolo e l’interpretazione di Glenn Ford e Maria Schell. La storia prende il via nell’Oklahoma del 1889, quando Yancey Gravat tenta senza successo di assicurarsi la terra e si conclude, attraverso un travaglio di quarant’anni, con la morte del protagonista, che non rinuncia ai propri ideali, lasciando alla moglie il compito di continuare a battersi per una società più giusta ed egualitaria.
L’altro romanzo di Edna Farber è “Il gigante”, scritto nel 1952 e adattato per lo schermo da George Stevens quattro anni più tardi.
Il film ebbe una grande risonanza, anche per la presenza fra gli attori – oltre ai collaudati Rock Hudson ed Elizabeth Taylor – di James Dean, l’idolo delle nuove generazioni, tragicamente scomparso in un incidente automobilistico durante le ultime fasi della lavorazione.
“The Giant” è un capolavoro del cinema western della Quarta Frontiera, narrando, come “Cimarron”, la lunga e difficile performance del West, nella quale i protagonisti Dirk Benedict (Hudson) sua moglie Leslie (Taylor) ed il mandriano Jett Rink (Dean) si trasformano da allevatori di bestiame in produttori di petrolio. Il tema di questo secondo film ricalca a grandi linee quello del primo ed è ispirato ad un solido ottimismo: il passaggio da un modello naturale di società alla sua fase industriale non riesce a disgregare – come invece avverrà più tardi nelle opere di Larry Mc Murtry – il nucleo familiare del vero pioniere. Alla fine, l’uomo del West riesce ad adattarsi al nuovo ruolo che il progresso gli assegna, mantenendo sostanzialmente immutati i propri ideali. La Ferber, malata di cancro, sì spense nel 1968 all’età di 82 anni.
Molte altre donne si segnalarono come sceneggiatrici di film western importanti, fra le quali merita una menzione Sonya Leven (1888-1960) per “The Cowboy and the Lady” di H. C. Potter del 1938 e “Drums Along the Mohawk” (“La più grande avventura”) di John Ford, tratto dal romanzo di Walter D. Edmonds e distribuito nel 1939. Al di fuori del genere western, la Leven aveva anche partecipato alla sceneggiatura di “Quo Vadis”, di Mervin Le Roy (1951).
The Cowboy and the Lady
Carol Eastman (1934-2004) che compare anche con lo pseudonimo di Adrien Joyce, curò invece le sequenze di “The Shootist” (“La sparatoria”) di Monte Hellman, nel 1966, un film meno noto di altri della stessa epoca, che risente già dell’influsso revisionista.
La lunga rassegna delle autrici che contribuirono al successo del genere western non si conclude certo qui, ma la sintesi presentata non sarebbe completa senza menzionare un romanzo, scritto in tempi moderni, che suscitò una viva impressione a livello mondiale, soprattutto dopo che il regista Ang Lee ne diresse la versione cinematografica.
“Gente del Wyoming” (titolo originale “Brokeback Mountain”) venne prodotto nel 1999 da Edna Annie Proulx, una romantica signora del Connecticut che aveva iniziato a scrivere all’età di 53 anni. E’ la storia di una tormentata relazione “gay” fra due cow-boys assoldati come guardiani di pecore in una località del Wyoming. Benchè entrambi sposati e con prole, non resistono alla tentazione di rivedersi periodicamente per continuare la loro storia segreta, fino a quando uno dei due non muore misteriosamente. Il suo compagno, Ennis Del Mar (l’attore Heath Ledger, deceduto nel suo appartamento di New York il 22 gennaio 2008, a soli 28 anni, per una intossicazione acuta) ne rivive il ricordo “nella sconfinata tristezza delle pianure settentrionali”. Il moderno West presentato dalla Proulx e magistralmente trasferito sullo schermo da Lee, somiglia a quello di molti altri film crepuscolari, da “Hud il selvaggio” di Martin Ritt (1963) a “L’ultimo spettacolo” (1971) di Bogdanovich, entrambi ricavati da romanzi di Mc Murtry. Ritrae una vicenda semplice ed al tempo stesso “dannatamente complicata” di uomini che “provenivano da due piccole, misere fattorie agli angoli opposti dello Stato… entrambi ragazzi di campagna che avevano lasciato la scuola alle superiori, senza prospettive…”.
In “Brokeback Mountain” non vi è soltanto la crisi del West che ha smarrito i propri valori, come nei due precedenti film citati. Il tramonto della vecchia Frontiera coinvolge l’intero contesto sociale, disorientato e sbalordito di fronte alla dissoluzione della propria immagine tradizionale, al mito dell’uomo virile, ai sani principi della famiglia e dell’onore.
Gli eredi di una leggenda che ha perso i suoi trionfalismi sono semplicemente degli esseri umani, con tutte le debolezze, le pulsioni e le insicurezze degli uomini in balia di un mondo che li osserva per un istante con occhi increduli, proseguendo subito nella sua marcia inarrestabile.
“Restava” scrive la Proulx alla fine del suo libro, focalizzando l’obiettivo sullo smarrito Ennis “ uno spazio vuoto tra ciò che sapeva e ciò che voleva credere, ma non ci poteva far niente, e se non la puoi risolvere devi prenderla com’è.”
Pagine di questo articolo: 1 2
